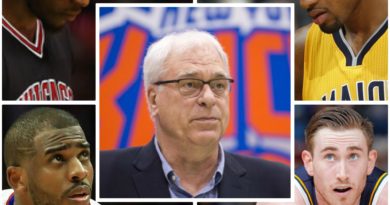Strength in Numbers
Senza Durant, i Warriors hanno riscoperto la loro vecchia filosofia di gioco
Strength in Numbers, ovvero la forza nei numeri. È questo il canto di battaglia che da diversi anni accompagna i Golden State Warriors nei loro viaggi ai playoff, così come anche quest’anno alla conquista del possibile three-peat. Lo slogan, che ha fra gli illustri predecessori l’altrettanto popolare We Believe del 2007, sta assumendo in questi giorni un nuovo significato. All’origine, richiamava non solo il supporto di una fanbase a secco di titoli da 40 anni, ma soprattutto la notevole profondità del roster. Nel 2015, anno del primo trofeo dell’era Steve Kerr, i Warriors si trovarono in Gara 1 delle Finals a inseguire i Cleveland Cavaliers sul -15 e per ribaltare il risultato in OT fu fondamentale l’apporto dalla panchina dei senatori Shaun Livingston e Andre Iguodala, più quello di role player come Barbosa, Speights ed Ezeli. Tuttavia, anno dopo anno la profondità e il contributo della panchina sono diventati sempre più marginali a fronte dell’esplosione del quintetto noto prima come Death Lineup e poi come Hamptons Five. Proprio l’arrivo nella Baia di un futuro Hall of Famer come Kevin Durant sembrava aver di fatto reso obsoleta la filosofia della forza nei numeri. Allo stesso modo, il suo recente infortunio l’ha riportata in auge più forte che mai.
L’inaspettato KO di KD in Gara 5 contro gli Houston Rockets aveva attirato una folta schiera di avvoltoi in volo circolare su Oakland. Con la serie sul 2-2, i razzi avevano la chance di portarsi in vantaggio e poi chiudere la serie in Texas. Nonostante la vittoria di carattere, nel post-partita molti media autorevoli dubitavano delle chance dei Warriors di vincere la serie, con Charles Barkley in testa alla carovana di chi li dava addirittura per spacciati. Da un punto di vista mentale, è facile supporre che ciò abbia fornito ai campioni in carica quella scossa nell’orgoglio che solo l’essere dubitati può dare. Specie quando da ormai un lustro quasi ogni gara li ha visti come i netti favoriti, e a maggior ragione perché la lunga ombra gettata dall’assenza di KD aveva contorni assai indistinti: addio per qualche partita, per il resto dei playoff o addirittura per sempre? Da un punto di vista tattico, ciò ha significato il ritorno in pompa magna dei Warriors pre-Durant, con ipnotiche circolazioni di palla e rotazioni allungate, seppure in contemporanea contumacia di DeMarcus Cousins.
autorevoli dubitavano delle chance dei Warriors di vincere la serie, con Charles Barkley in testa alla carovana di chi li dava addirittura per spacciati. Da un punto di vista mentale, è facile supporre che ciò abbia fornito ai campioni in carica quella scossa nell’orgoglio che solo l’essere dubitati può dare. Specie quando da ormai un lustro quasi ogni gara li ha visti come i netti favoriti, e a maggior ragione perché la lunga ombra gettata dall’assenza di KD aveva contorni assai indistinti: addio per qualche partita, per il resto dei playoff o addirittura per sempre? Da un punto di vista tattico, ciò ha significato il ritorno in pompa magna dei Warriors pre-Durant, con ipnotiche circolazioni di palla e rotazioni allungate, seppure in contemporanea contumacia di DeMarcus Cousins.
Se, ad esempio, in Gara 4 contro Houston solo tre giocatori si erano alzati dal pino per almeno un minuto, nella successiva Gara 6 hanno timbrato il cartellino undici giocatori in totale, con minutaggi delle riserve dai 7 ai 20 minuti. Chi ha indirettamente beneficiato più di tutti del nuovo assetto è però senza dubbio Steph Curry, da tre anni ostaggio volontario dell’apparente equivoco che lo vede non il Warrior più forte, ma di certo quello più importante. Nelle tre partite intere giocate senza KD, il marito di Ayesha si è scatenato, con medie da 35.3 punti, 6.3 rimbalzi, 6.3 assist, con il 49% dal campo e il 100% ai liberi. Non è un mistero che Steph sia stato il Warrior che più di tutti ha dovuto compiere i sacrifici maggiori dall’arrivo di KD.
Certo, tale coesistenza gli ha fruttato altri due anelli, ma ha fatto dimenticare a molti fan che fino al 2016 lui era pur sempre un due volte MVP. La crescita di Steph e il ritorno dei role player hanno mantenuto i Dubs imbattuti, ma non senza qualche brivido. In Gara 2 contro i Portland Trail Blazers, i Dubs sono arrivati anche a -17, ma una furiosa rimonta nel secondo tempo li ha portati alla terza W consecutiva. Tale persistente invincibilità ha scatenato ancora di più chi attende con ansia che la free agency di KD lo porti dovunque, purché lontano dagli Splash Brothers. Così facendo, la lega diventerà più equilibrata, ma con queste ultime partite i Warriors hanno lanciato un messaggio chiaro: anche senza Durant, la loro forza è ancora nei numeri. Soprattutto quelli di Steph.
MVProf