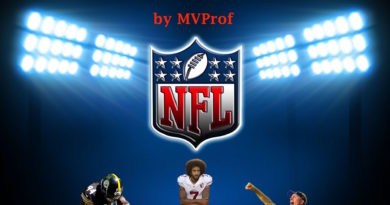Mercatone e mercatini
La dimensione dei mercati NBA non ha mai avuto così poco peso
Ormai ci siamo: ancora pochi giorni, e si aprirà ufficialmente la free agency. Con tante stelle NBA pronte a ricevere offerte faraoniche dalle squadre interessate ai loro talenti, il panorama dell’Association potrebbe essere assai diverso il prossimo ottobre. Al di là dei giocatori sul mercato, l’estate 2019 è resa ancora più avvincente dall’ampia disponibilità economica delle squadre dei maggiori mercati NBA. Come risaputo, entrambe le squadre di New York hanno abbastanza spazio per due contratti al massimo salariale, così come quelle di Los Angeles potranno firmare almeno una (altra) superstar. Se ci si basasse solo sulle voci più o meno autorevoli che si rincorrono in questi giorni, parrebbe che ciascuna di queste quattro squadre sia a un passo dal mettere sotto contratto uno per uno tutti i migliori giocatori. All’apparenza, sembra che queste e molte altre big city siano pronte a fare jackpot, ma in realtà ciò non è scontato. Se analizziamo la qualità del recruiting delle 30 squadre NBA nell’ultima decade, ci accorgiamo che sono le franchigie più note ad avere sulla coscienza la lista più lunga di abbagli presi.
Dal 2010 a questa parte, i New York Knicks dello sciagurato James Dolan hanno bruciato centinaia di milioni con le spese forse più dissennate di tutti, come dimostrato con Amar’e Stoudemire (2010), Robin Lopez (2015), Courtney Lee e Joakim Noah (2016) e infine Tim Hardaway jr (2017). Discorso simile per i Los Angeles Lakers, che con la morte di Jerry Buss hanno come perso la loro anima e sono finiti a regalare contratti folli a mestieranti come Timofey Mozgov e Luol Deng (2016). Come non citare poi i disastri dei Brooklyn Nets nella loro caccia – via trade – ai resti umani di Pierce e Garnett (2013) e che i Los Angeles Clippers hanno passato gran parte della loro storia come la più grande barzelletta della lega? Non molto meglio sta andando ai Chicago Bulls in mano al contestatissimo duo GarPax o ai Dallas Mavericks di Cuban, grandi scialacquatori di dollari e, come se non bastasse, di recente pure travolti da uno scandalo sessuale. Insomma, l’unico grande nome che in questi anni ha scelto uno di questi mercati è LeBron James, e il suo arrivo ai Lakers non solo era scontato, ma anche legato a molte contingenze extra-basket.
A ben vedere, se la scelta di giocatori come KD, Leonard e Kyrie si dovesse basare unicamente sulla fama e il rispetto dei management dei cosiddetti grandi team, questi dovrebbero starne alla larga. Di contro, tali grandi piazze hanno il lusso di poter contare su amplissime possibilità imprenditoriali e su una larga fan base che assicura al team di riempire agevolmente i seggiolini dell’arena a prescindere dalla qualità dello spettacolo proposto. In tal modo, le malefatte manageriali di questi team passano in secondo piano e, spinti dalla fanfara ricca di retorica dei media, ad ogni sessione di free agency paiono sempre e comunque in prima linea per i migliori talenti a disposizione. Pur essendo in questi anni diminuita l’assoluta necessità da parte delle grandi star di legarsi alle grandi città per far emergere ed evolvere il proprio brand, come la maggior parte dei comuni mortali, anche loro sceglieranno il più delle volte di vivere a New York o LA  rispetto a Charlotte o Salt Lake City. Ciò fa solo apprezzare maggiormente chi, pur operando nei cosiddetti small market, dimostra che è possibile dar vita a grandi realtà di basket.
rispetto a Charlotte o Salt Lake City. Ciò fa solo apprezzare maggiormente chi, pur operando nei cosiddetti small market, dimostra che è possibile dar vita a grandi realtà di basket.
Il caso più emblematico è rappresentato dai San Antonio Spurs, campioni NBA per 5 volte e da ben 22 anni capaci di chiudere la stagione con un record positivo guidati dal generale Gregg Popovich. Impossibile scordare i Phoenix Suns di Mike D’Antoni, che a metà degli anni 2000 giocavano non solo quello che era di gran lunga il basket più divertente della lega, ma che è oggi evoluto in un sistema imitato da molti. Un esempio recente di virtù proviene dai vicini di casa degli Oklahoma City Thunder, i quali, arrivati a testa bassa da Seattle nel 2008, sono da diversi anni una presenza fissa ai playoff. A est, solo applausi per la stagione appena conclusa dai Milwaukee Bucks, che con Giannis Antetokounmpo avranno diversi anni per puntare a quel titolo appena vinto da dei Toronto Raptors che, pur operando a meno di 90 miglia dal confine americano, vengono storicamente associati alla Siberia cestistica. Il caso dei Cleveland Cavaliers rappresenta la classica eccezione alla regola: un management spesso inadeguato è stato favorito oltremodo da un destino amico che ha fatto nascere un talento assoluto come King James nel giardino di casa.
Proprio pochi giorni fa, il caso ha voluto che l’ultimo draft abbia portato una cospicua dote ai due mercati più piccoli della lega, ovvero New Orleans e Memphis, attraverso l’arrivo di Zion Williamson e Ja Morant. Indicativo è soprattutto il caso di Zion, che giunge ai New Orleans Pelicans contestualmente all’addio di un’altra ex prima scelta assoluta come Anthony Davis. Nei sette anni passati a NOLA non si può rimproverare nulla all’ex Kentucky, che a livello personale ha raccolto 6 presenze all’All-Star Game, 3 selezioni per il primo team All-NBA e una lunga serie di record di squadra. Al contrario, in un mix di sfortuna e scelte infelici, i Pelicans non sono riusciti a circondare Davis con un supporting cast in grado di esaltarne le doti, per di più cambiando in quello stesso periodo tre allenatori e due GM. A quel punto, è naturale che il monociglione abbia preso al balzo la chance di emigrare altrove e forzare la mano alla franchigia in direzione LA. Il contemporaneo arrivo di Zion in città dà quindi ai Pels un’ottima chance per redimere i loro recenti fallimenti con AD e costruire una squadra in grado di lottare per il titolo già dai prossimi anni.
A dare ulteriore ossigeno alla sopravvivenza dei piccoli mercati ci ha pensato la lega stessa, che in questi anni ha aumentato gli incentivi per far massimizzare alle piccole squadre le proprie chance di tenersi strette le proprie stelle. In base alle nuove regole, una squadra può estendere un proprio giocatore scelto al draft già dopo il terzo anno e, con la cosiddetta “Derrick Rose rule,” designare un giocatore per un’ancor più ricca estensione. Dal settimo anno di servizio, possono poi offrire un supermax per un massimo di 5 anni al 35% del cap a disposizione. Tuttavia, avere la facoltà di offrire più soldi e anni di chiunque altro non può essere la panacea in grado di curare il vero problema alla radice, ovvero anni di negligenza e imperizia manageriale – quella sì senza confini. Il caso di Davis giunge di nuovo come miglior esempio, ma sono simili anche i casi recenti di Kyrie e Kawhi. In conclusione, questa generazione di superstar ha dimostrato di non farsi incantare dalle sirene delle grandi piazze, e nemmeno dal mero numero di mazzette gettate sul tavolo: al contrario, ha scelto di reclamare per sé una maggiore libertà di scegliere il miglior progetto a tutto tondo da sposare.
MVProf